da Rivista Malamente n. 26 (set. 2022) QUI IL PDF
Nei nostri manuali di letteratura francese Jean Giono (1895-1970) è ricordato in poche pagine come il cantore dell’idillio contadino, il romanziere di una felicità bucolica immersa in gioia di vivere e assenza di conflitti. Il pensiero di Giono non è in realtà così ingenuo e infatti la sua opera è stata rivalutata dai critici più attenti che ne hanno colto la tensione di base nell’interrogativo sulla condizione umana: nei suoi scritti, la presunta armonia uomo-natura e l’esaltazione della frugalità servono, di riflesso, a condannare l’invivibilità della società contemporanea, urbana e capitalistica, perennemente votata al progresso industriale e alla ricerca del profitto. Approfondiamo la figura di questo romanziere con un suo profilo biografico e alcuni estratti dei suoi libri (non tutti disponibili in traduzione italiana).

Giono precursore della decrescita
Serge Latouche inserisce Giono nel suo pantheon dei precursori del pensiero della decrescita: «il rifiuto della società industriale da parte di Giono non era un semplice atto di reazione nei confronti di un mondo moderno in rapida trasformazione. Se Giono promuoveva ostinatamente l’ideale di una ruralità autonoma e autarchica non era soltanto per la nostalgia di un mondo che probabilmente non è mai esistito, ma perché era convinto che soltanto una ripresa di contatto dell’uomo con il suo ambiente naturale, grazie a un modo di vita al riparo dai misfatti dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione, potesse consentire di resistere efficacemente al totalitarismo economico e sociale instaurato da una tecnica onnipotente».[1]
Per Giono i contadini, quando sanno sottrarsi agli imperativi della produzione per il mercato agricolo, diventano motore della rivoluzione anticapitalista, antindustriale e antistatale. È infatti nel mondo rurale che è ancora possibile ritrovare sobrietà, lentezza e convivialità da opporre a una società che nella sua perpetua rincorsa allo sviluppo finisce per produrre disastri ecologici su vasta scala e per rendere individui e comunità sempre più dipendenti da un’organizzazione socio-economica a loro esterna ed estranea. È la campagna che ridona tanto senso all’esistenza collettiva sul pianeta quanto la condizione urbana gliene sottrae, perché il ritmo della natura è proprio dell’uomo in quanto essere sensibile, mentre il ritmo industriale è una violenza che lo riduce a ingranaggio della macchina.
Il pensiero di Giono, purtroppo, è stato sfruttato anche dalla destra più reazionaria, rendendolo vittima di un malinteso circa la sua presunta vicinanza con il regime collaborazionista di Vichy. Niente di più falso. Il suo richiamo alla terra e alle tradizioni e la sua apologia della famiglia contadina (affatto condivisibile, va detto, nei suoi aspetti di cultura patriarcale) non avevano nulla a che vedere con il “sangue e suolo” dell’ideologia nazifascista, né con il vagheggiare un ritorno alla Francia nazionalista e rurale. L’ostracismo che lo ha colpito, costandogli anche il carcere subito dopo la Liberazione, è piuttosto dovuto al suo volontario isolamento, al suo rifiuto di schierarsi sotto qualsivoglia bandiera politica, se non quella del pacifismo integrale.

Una vita per la letteratura e il pacifismo
Jean Giono nasce a Manosque, in Alta Provenza, nel 1895 da una famiglia di origini piemontesi; il nonno, disertore, probabilmente carbonaro, era fuggito dall’Italia. Il padre, di spirito anarchico, fa di mestiere il calzolaio; la madre è stiratrice.
Jean rigetta le divise e l’ambiente militare. A diciotto anni, nel 1913, rifiuta di addestrarsi nel gruppo dei suoi compagni, ma due anni dopo viene mobilitato sui campi della grande guerra: «nel 1915 sono partito senza credere nella patria. Ho avuto torto. Non di non credere: di partire». L’esperienza è decisamente traumatica e radicalizza la sua avversione verso la guerra. Ricordando quei tempi, e anche pentendosi di non essersi apertamente ribellato, scrive: «nessuna azione eclatante. Sono sicuro di non aver ucciso nessuno. Ho fatto tutti gli attacchi senza fucile, o meglio con un fucile inutilizzabile. Tutti i sopravvissuti alla guerra sanno come sia facile con un po’ di terra e di urina rendere un Lebel come un bastone. Non ho vergogna ma, a ben vedere, quello che facevo era una vigliaccheria. Avevo l’aria di accettare. Non avevo il coraggio di dire: “Non vado all’attacco”. Non ho avuto il coraggio di disertare. Non ho che una sola scusa: la mia giovane età. Non sono un vigliacco. Sono stato tradito dalla mia giovinezza e anche ingannato da coloro che sapevano che io ero giovane. Loro erano perfettamente informati. Sapevano che avevo vent’anni».[2]
L’impronta pacifista senza ripensamenti né mezze misure, integrale, convinta – fin troppo…! – segna da quel momento in poi tutta l’opera letteraria di Giono, caratterizzata dal rifiuto viscerale di ogni guerra: «che siano difensive, offensive, civili, per la pace, per i diritti, per la libertà, tutte le guerre sono inutili».[3] Più che altro, dice, sono un modo di continuare a far affari. «La guerra non è una catastrofe, è un mezzo di governo»[4], scrive Giono; e se la guerra moderna è il portato inevitabile della società capitalistica, delle economie che si contendono gli spazi, nonché il trampolino di lancio delle tecnologie industriali, allora, non esistendo più un “fuori” da questa società, l’unica salvezza si trova ai suoi margini, nel mondo contadino. Qui, nell’ambiente rurale, ci sono le «vere ricchezze» (Les vraie richesses è il titolo di un suo romanzo del 1936): mangiare un frutto dall’albero, rispettare le stagioni, ricercare la gioia di vivere. Ecco che il pacifismo contadino diventa rivoluzionario, proprio perché si oppone irriducibilmente alla guerra perpetua della moderna società industriale.
Nelle opere degli anni Trenta, Giono tende a distaccarsi da un certo romanticismo bucolico per interrogarsi politicamente, in maniera impegnata, su come uscire dal disastro e dare vita a una forma di società migliore, il cui pilastro resta sempre e comunque, per lui, il mondo contadino, intrecciato alle attività di pastori, allevatori, artigiani e artisti. Giono ha una conoscenza non superficiale della teoria marxista, ha simpatie per la sinistra e «una forte tendenza anarchica ereditata da suo padre», ma non ha nulla del classico militante politico.[5]
Nel 1934 aderisce all’AEAR (Associazione degli scrittori e degli artisti rivoluzionari), vicina al Partito comunista, «per cessare di essere inutile – scrive –. Per avere dei compagni. Per poter concertare un’azione».[6] Ma si tratta solo di un breve flirt, maturato esclusivamente su posizioni pacifiste. Le bandiere non fanno per lui, che già l’anno successivo annota: «diffido sempre più dei comunisti», pur mantenendo il suo impegno nei circoli intellettuali antifascisti. E, ancora: «non riconosco nessuna patria, né la Francia, né la Russia e non voglio difendere niente, neanche la dittatura del proletariato. […] Diserto l’armata rossa come diserto l’esercito francese. Io diserto tutti gli eserciti».[7] Una posizione, come si vede, non allineata, fuori dagli schemi, che gli causerà non pochi guai, a destra come a sinistra.

Nel 1935 vicino alla sua Manosque, in una fattoria sull’altopiano del Contadour, inizia l’avventura di un cenacolo culturale di artisti, insegnanti, artigiani, operai, tra loro anarchici, socialisti e comunisti, con in comune l’amore per la natura, il pacifismo e l’antifascismo, una «abitazione di speranza»[8] che però non riesce a dar luogo né a una vera e propria comunità rurale né a un circolo di dissidenza politica e nonostante il progetto del 1937 di una campagna di rifiuto contro un’eventuale guerra, si sfalda due anni dopo, quando la guerra arriva davvero.
Nel frattempo Giono fantastica su un’altra via d’uscita, meno pacifica ma forse più risolutiva: una grande e moderna jacquerie contadina che spazzi via industriali e politici, distrugga fabbriche e palazzi e per finire rada al suolo il centro di questa civilizzazione, la capitale, Parigi, per far sì che la natura ricostruisca sulle sue macerie: «e aggiungo che se potessi fermare l’avanzata di questo magnifico mostro non lo farei, piuttosto l’affretterei. Voi altri, a Parigi, non vi rendete conto che puzzate, ma da noi, qui, ci sono dei giorni, quando soffia il vento dalla vostra parte, in cui il vostro fetore ci sovrasta».[9] Lavora per un paio di anni a questo romanzo di resistenza contadina, lasciandolo però incompiuto. I suoi temi forti sono infatti altri: nel 1937 pubblica Rifiuto d’obbedienza, nel 1938 esce la Lettera ai contadini sulla povertà e la pace.
Intanto, il clima europeo non promette nulla di buono. Tempi duri per i pacifisti, di fronte all’ascesa del nazismo. Giono firma appelli e petizioni per il disarmo e non cede alla tentazione di dover combattere – «non ho vergogna di nessuna pace, ho vergogna di tutte le guerre» – neanche dopo l’annessione dell’Austria alla Germania, neanche dopo l’invasione della Cecoslovacchia. Rifiuta di sospendere e riconsiderare il suo pacifismo assoluto «in parte per illusione, orgoglio o forse ostinazione. Ma soprattutto per senso del dovere e della fedeltà a se stesso».[10] Di certo non si rende conto della specificità del nazismo e, per malintesa coerenza, antepone l’etica pacifista alla necessaria azione antifascista proprio quando sarebbe stato il caso di agire, ognuno con i suoi metodi, dalla penna alla spada, per sbarrare la strada alla guerra.
Invece una nuova guerra, nel 1939, arriva. Giono e alcuni amici girano i paesi attorno a Manosque attaccando biglietti con scritto “No” sui manifesti di arruolamento. Ma una profonda crisi di coscienza lo attanaglia: medita di darsi alla macchia, di fuggire in Svizzera. Infine si lascia mobilitare anche per questa guerra, probabilmente per non abbandonare a loro stesse la moglie e le due figlie. Viene reclutato a Digne, fatto sta che dopo pochi giorni è imprigionato per propaganda antimilitarista, in base ai suoi scritti contro la guerra ancora in circolazione.
Un secondo arresto lo attende all’indomani della Liberazione, tra agosto 1944 e gennaio 1945. Come già detto, il suo tema del “ritorno alla terra” era stato fatto strumentalmente proprio dal regime di Vichy; un suo romanzo, da cui non traspariva la benché minima simpatia nazifascista, era uscito sulla rivista collaborazionista “La Gerbe” e, a sua insaputa, un’altra rivista collaborazionista aveva ospitato un reportage su di lui e la sua opera. Mettendo in fila tutto questo, i comunisti gli fanno scontare con il carcere la sua indipendenza di spirito dimenticando quanto Giono avesse concretamente aiutato negli anni di guerra gli oppositori del regime, nascondendo rifugiati ebrei, tedeschi antinazisti e resistenti. «Consideravo senza importanza – scrive sbalordito – il fatto che La Gerbe avesse pubblicato Deux cavaliers. Cos’era questo in confronto a ciò che facevo ogni giorno?»[11] Giono verrà in seguito riabilitato e continuerà la sua opera letteraria, tanto da meritare un posto nella prestigiosa collana Bibliothèque de la Pléiade, portandosi però dietro, anche attraverso i suoi personaggi, i segni della delusione e dell’ingiustizia subita.
Pubblichiamo qui di seguito la traduzione di alcuni estratti delle sue opere Les Vraies richesses, Refus d’obéissance, Le poids du ciel (traduzioni nostre) e Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix (Ponte alle grazie, 2004).

Le vere ricchezze (1936)
Per chi è nato in cattività, la libertà non è più un alimento. Fino alle 9 del mattino la strada è il corridoio per coloro che vanno al lavoro. E il lavoro, qui, non è più a misura d’uomo, né della sua gioia, né del suo cuore. È diventato orrendo, inutile e divoratore. Sembra che esista solo per utilizzare del materiale umano. Non funziona più seguendo le leggi naturali di trasformazione. Non si serve più dell’ammirevole senso industrioso dell’uomo. È impersonale, collettivo, dà più che altro impressione di vuoto e inutilità, e distrugge ogni giorno la bellezza della vita di mezzo milione di esseri viventi. Niente di ciò che crea ha delle qualità. Gli oggetti fabbricati che tocco hanno invisibili sbavature dove si aggrappa e si irrita la pelle delle mie dita. Nessuno fa gioire le mie mani. La loro materia è agonizzante. L’operaio non ha avuto né il tempo, né la voglia e non ha più lo spirito di conservare la vita alla materia che lavora. È vero che per la maggior parte del tempo quello che riceve è ingratitudine e cattiva salute. Non si vogliono più fare cose belle. Vanno fatte in fretta, a buon mercato e molte. Mi si propone, timidamente, di accogliere queste povere cose. Non possono offrirmi niente. Ma io non le respingo. Le guardo con tristezza come il legno di una croce sulla quale si crocifiggono inutilmente uomini e donne ogni giorno.
[La folla] è come la solitudine. Ma, quindi, ha il suo fascino? No, è una solitudine che non vi appartiene, infeconda; una solitudine che è separazione e non unione dei migliori spiriti attraverso le distanze, una solitudine che non è armonia e divino concerto, ma silenzio totale dell’anima per soffocamento. […]
Di tutte queste persone che mi circondano, mi trascinano, mi urtano e mi spingono, di questa folla parigina che scorre sul marciapiede davanti a La Samaritaine, quanti sarebbero capaci di recuperare i gesti essenziali della vita se si trovassero domani all’alba di un mondo nudo?
Chi saprebbe orientare un focolare all’aperto e fare un fuoco?
Chi saprebbe riconoscere e selezionare tra le piante velenose quelle commestibili come lo spinacio selvatico, la carota selvatica, le rape di montagna, i cavoli dei pascoli?
Chi saprebbe tessere le stoffe?
Chi saprebbe trovare le sostanze per fare il cuoio?
Chi saprebbe scuoiare un capretto?
Chi saprebbe conciare la pelle?
Chi saprebbe vivere?
Ah! Finalmente adesso la parola designa la cosa!
Io vedo che cosa questi sanno fare: sanno prendere l’autobus e la metro. Sanno fermare un taxi, attraversare la strada, ordinare al cameriere del bar; e lo fanno con un’agiatezza che mi deconcentra e mi spaventa.
Sono stupito come lo sono stato allo zoo di Berlino davanti alla gabbia del gorilla quando ho visto la bestia sedersi su una sedia, di fronte a un tavolo, e attendere la sua sbobba.
“Come un signore”, ha detto qualcuno che mi accompagnava.
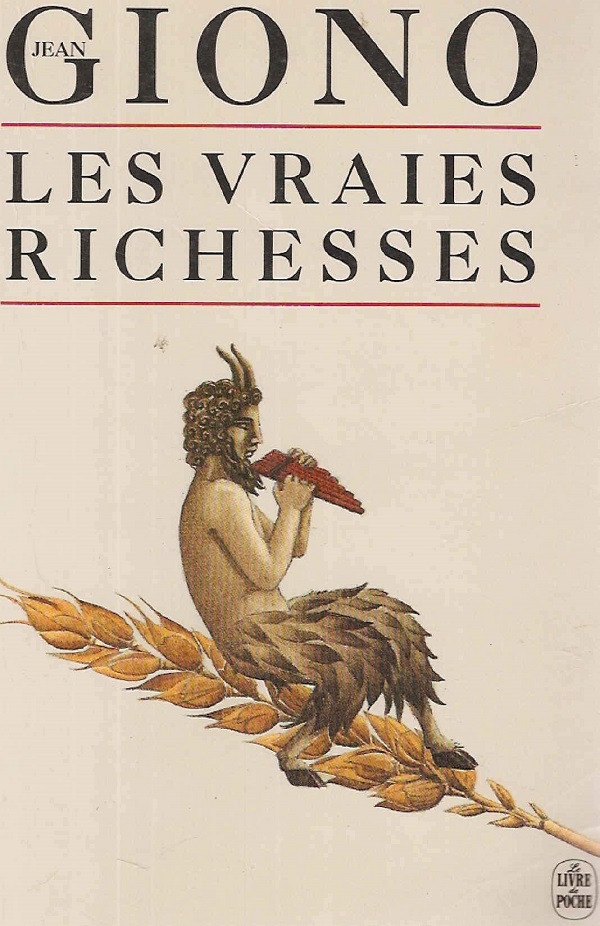
Rifiuto di obbedienza (1937)
Quello che mi disgusta della guerra è la sua imbecillità. Io amo la vita. Non amo che la vita. È molto, ma comprendo che la si sacrifichi per una causa giusta e bella. Ho curato malattie contagiose e mortali senza mai risparmiarmi. Ma in guerra ho paura, ho sempre paura, tremo, me la faccio nelle mutande. Perché è stupido, perché è inutile. Inutile per me. Inutile per il compagno che è con me sulla linea di tiro. Inutile per il compagno di fronte. Inutile per il compagno che è al fianco del compagno di fronte, nella linea di tiro che avanza verso di me. Inutile per il fante, per il cavaliere, per l’artigliere, per l’aviatore, per il soldato, il sergente, il tenente, il capitano, il comandante. Attenzione, stavo per dire: il colonnello! Sì, forse anche il colonnello, ma fermiamoci. Inutile per tutti coloro che sono sotto la macina, per la farina umana. Utile per chi, allora?
La guerra non è una catastrofe, è un mezzo di governo. Lo Stato capitalista non conosce uomini che cercano quella che noi chiamiamo felicità, uomini che sono quel che sono, uomini in carne e ossa; non conosce che una materia prima per produrre del capitale. Per produrre del capitale ha, in certi momenti, bisogno della guerra, come un falegname ha bisogno di una pialla, lo Stato si serve della guerra. Il bambino, gli occhi azzurri, la madre, il padre, la gioia, la felicità, l’amore, la pace, l’ombra degli alberi, la freschezza del vento, la corsa saltellante delle acque, lui non le conosce. Non riconosce nel suo stato, nelle sue leggi, il diritto di gioire delle bellezze del mondo in libertà. Economicamente, non lo può riconoscere. Ha leggi solo per il sangue e per l’oro. Nello Stato capitalista quelli che gioiscono, gioiscono solo per il sangue e l’oro. Quello che viene detto dalle sue leggi, dai suoi professori, dai suoi poeti accreditati è che bisogna avere il dovere di sacrificarsi. Bisogna che io, tu e gli altri ci sacrifichiamo. Per chi? Lo Stato capitalista ci nasconde con garbo il cammino verso il mattatoio: vi sacrificate per la patria (non si osa quasi più dirlo) e, in fin dei conti, per il vostro prossimo, per i vostri bambini, per le generazioni future. E così di seguito, di generazione in generazione. E dunque, alla fine, chi mangia i frutti di questo sacrificio?

Lettera ai contadini sulla povertà e la pace (1938)
Non siete obbligati, voialtri, a passare attraverso il denaro. Ci passate soltanto perché vi hanno sviliti. Quel che io sono obbligato a comperare, voi lo producete direttamente. Che bisogno avete di trasformare il vostro frumento in denaro, se in fin dei conti la vostra necessità di vivere vi costringerà sempre a ritrasformare quel denaro in frumento? Fate passare il frumento direttamente alla vostra vita. Voi siete fuori dal sociale. Voi potete, dall’oggi al domani, senza fatica, essere liberi e autonomi. Senza bisogno di denaro, potete sempre riempire abbondantemente la vostra tavola coi cibi migliori. È impossibile che moriate di fame. Si tratta di sapere se pensate ancora che esser ricchi significhi avere molti di quei pezzetti di carta con dei numeri stampati sopra; e se continuate a dire che è povero colui che, privo di denaro, ha una cantina piena di buon vino, un granaio pieno di frumento, una dispensa piena di verdure, una stalla piena di pecore, un cortile pieno di polli, una conigliera piena di conigli, il mondo intorno a sé e del tempo libero a disposizione.
L’artigiano calzolaio ora è diventato un operaio calzolaio. Lavora da Bata. Sa cucire un rinforzo. Mio padre ci metteva due ore per cucire un rinforzo. L’operaio di Bata ci mette appena mezz’ora. È più abile di mio padre, ma sa fare soltanto questo. Non sa fabbricare una scarpa intera. Cuce il suo rinforzo e passa il lavoro a un altro. Sfortunatamente per lui, nessuno al mondo ha bisogno di un rinforzo; si ha bisogno di scarpe finite. L’operaio non può lasciare la sua sedia da Bata. Se se ne andasse, non potrebbe vivere. Non ha più un mestiere che gli dia di che vivere ovunque. Può vivere soltanto se inserito al posto di cucitura dei rinforzi nel sistema Bata. Non può né spostarsi né vivere (poiché vivere è un’altra cosa rispetto a cucire rinforzi). È costretto a rimanere lì; ci si deve costringere fisicamente. È prigioniero e la sua famiglia è prigioniera. E se gli si danno quindici giorni all’anno di ferie pagate, vi dico che rispetto alle grandi vacanze perpetue di mio padre questo che chiamano progresso è soltanto una grave regressione. Io ho sempre avuto voglia di fare il calzolaio come mio padre. Non ho alcuna voglia di fare il calzolaio da Bata.
Siamo nell’ennesima moltiplicazione delle generazioni che la tecnica industriale ha ammassato nelle città. Là, non rimane più alcun uomo naturale. Ovunque sono loro a governare. Ovunque fanno le leggi, le leggi che dirigono la vostra vita, le leggi che incatenano al governo dello Stato, al loro governo, la conduzione della vostra vita e la decisione della vostra morte. Fanno come se voi non esisteste, voi, i contadini. Voi siete separati da loro in tutta la vostra natura e nella grande e semplice educazione logica che la natura ha dato al vostro corpo fisico e a tutto il vostro corpo sociale, ma voi siete la grande maggioranza degli uomini. Se in ogni nazione i contadini si unissero, formerebbero una massa dieci volte maggiore della massa degli uomini tecnici e ci si renderebbe subito conto che è per puro caso che la si governa contro la sua volontà, e che le cose stanno per cambiare. Se i contadini di tutte le nazioni del mondo si unissero – hanno bisogno delle medesime leggi –, in men che non si dica instaurerebbero su tutta la terra la regola della loro civiltà; e tutti i grotteschi governucoli – quelli che adesso sono padroni di tutto – finirebbero i loro giorni in blocco: parlamenti, ministri, capi di Stato tutti insieme, nelle celle imbottite di grandi manicomi. Per l’importanza primaria del suo lavoro e per l’incommensurabile moltitudine dei suoi uomini, la razza contadina è il mondo.
La povertà è lo stato della misura. Tutto è alla portata delle mani. Vivere è facile. Non dovete chiedere il permesso a nessuno. Lo Stato è un edificio di regole che creano artificiosamente un permesso di vivere e danno a certi uomini il diritto di disporne. In verità, niente e nessuno ha il diritto di disporre della vita di un uomo. […]
La forza dello Stato è il denaro. Il denaro dà allo Stato la forza dei diritti sulla vostra vita. Ma siete voi a dare forza al denaro; accettando di servirvene. Ora, voi siete umanamente liberi di non servirvene: il vostro lavoro produce tutto quel che è direttamente necessario alla vita. Potete mangiare senza denaro, avere un riparo senza denaro, garantirvi ogni avvenire senza denaro, perpetuare la civiltà umana senza denaro. Vi basta dunque un atto di volontà per diventare padroni dello Stato. Quel che il sociale chiama povertà, per voi è misura. Siete gli ultimi attualmente a poter vivere nobilmente con misura. E ciò vi dà una tale potenza che se accettate di vivere nella misura dell’uomo, tutto intorno a voi acquisirà la misura dell’uomo. Lo Stato diventerà quel che deve essere: il nostro servitore, non il nostro padrone. Avrete liberato il mondo senza battaglie. Avrete cambiato il senso dell’umanità intera, le avrete dato più libertà, più gioia, più verità di quanto le abbiano mai potuto dare tutte le rivoluzioni di tutti i tempi.
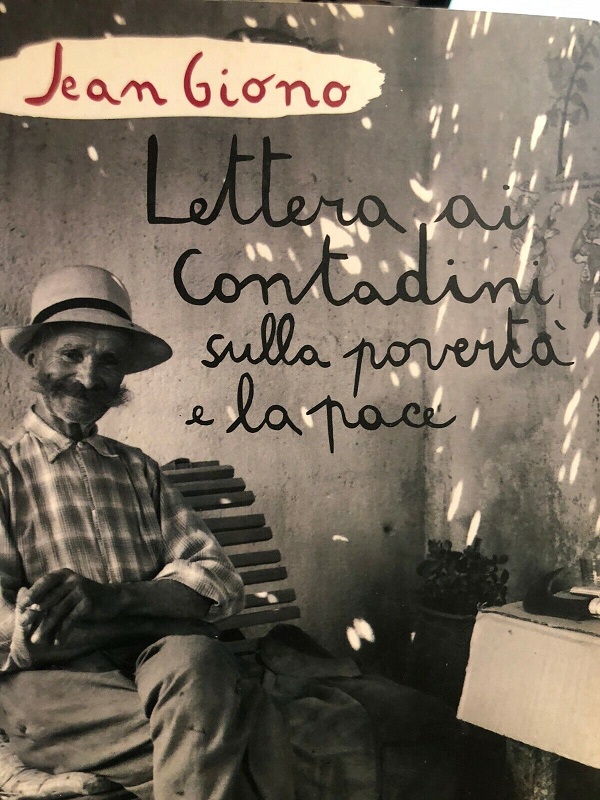
Il peso del cielo (1938)
Non rendendosi conto dell’esistenza della civiltà contadina e della sua eternità, le civiltà tecniche antinaturali, ancora nel periodo della loro infanzia (e incapaci di superarla, visto che passano da una guerra a un’altra), cercano di fare il benessere del mondo contadino. Non confidando che nella forza (e in un certo tipo di forza), vogliono fare questo benessere per forza. Non conoscendo la qualità del lavoro contadino, hanno voluto farlo eseguire tramite procedimenti tecnici; senza conoscere la qualità della fatica contadina, hanno preteso di volerla diminuire. Non voglio dire che una certa tecnica non possa aiutare il contadino; voglio dire che la tecnica così com’è, nella civiltà tecnica antinaturale, non può aiutare il contadino. È tutto il processo della tecnica: è tutto il processo di disperazione al sapore di ferro che ha installato sulla terra. Non per niente è da un po’ di tempo che, a proposito della civiltà tecnica, uso questo sgradevole termine di antinaturale. Ma indica bene ciò che voglio dire e ciò che questa civiltà è. Perché nel suo territorio, questa civiltà cerca di dominare la natura, di costringerla, di obbligarla, e poi di combatterla e vincerla e, nel segreto dei cuori, nascosto ai cuori stessi, di distruggerla. Ed è con lo stesso spirito che cerca di intervenire nel mondo contadino, credendosi ancora nel proprio territorio, mentre è nel territorio di una civiltà dallo spirito totalmente opposto al suo. Qui non si tratta più di combattere, vincere e distruggere! Si tratta di collaborare, di lavorare insieme.
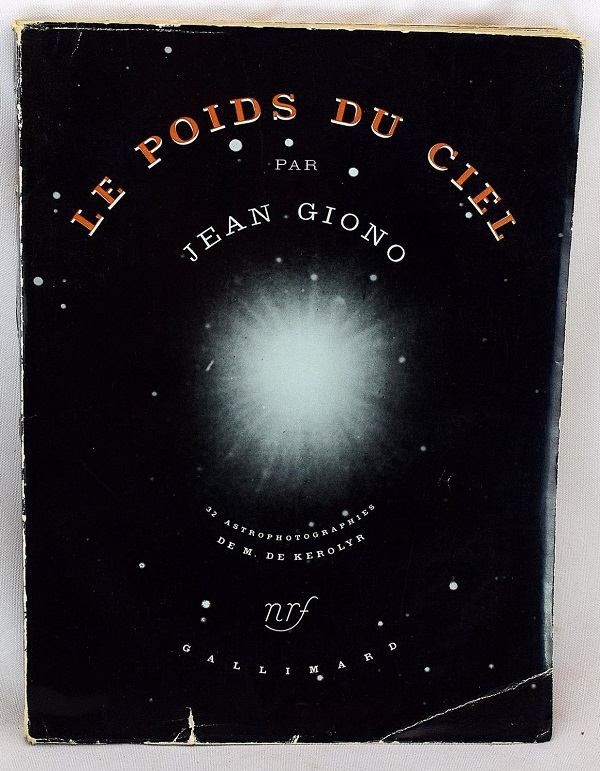
Bibliografia minima
Pierre Citron, Giono, 1895-1970, Parigi, Seuil, 1990.
Mireille Sacotte, De la guerre à la terre. Les idées politiques de Giono au temps des “Vraies richesses” (1929–1939), in Les vraies richesses: Giono dans la mêlée, Caen, Lettres modernes Minard, 2010, p. 75-117.
Édouard Schaelchli, Jean Giono, pour une révolution à hauter d’hommes, Neuvy-en-Champagne, Le Passager clandestin, 2013.

[1] Serge Latouche, La decrescita prima della decrescita. Precursori e compagni di strada, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 130.
[2] J. Giono, Refus d’obéissance, in Récits et essais, Parigi, Gallimard, 1989, p. 262.
[3] Id., Lettera ai contadini sulla povertà e la pace, Milano, Ponte alle Grazie, 2004, p. 90.
[4] Id., Refus d’obéissance, cit., p. 267-268.
[5] Marie-Paule Boutry, Jean Giono, romanziere pacifista, “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1989, n. 2, p. 36-37.
[6] Ivi.
[7] La prima cit. in Pierre Citron, Giono, 1895-1970, Parigi, Seuil 1990, p. 248; la seconda in M.-P. Boutry, Jean Giono, romanziere pacifista, cit., p. 36.
[8] J. Giono, Prefazione a Vraie richesses, in Récits et essais, cit., p. 148.
[9] Id., Oeuvres romanesques, v. 3, Parigi, Gallimard, 1974, p. 1268.
[10] P. Citron, Giono, 1895-1970, p. 297.
[11] Cit. in M.-P. Boutru, Jean Giono, romanziere pacifista, cit., p. 42.
Pingback: Jean Giono: la campagna, la pace, la rivoluzione – Rivoluzione Anarchica 🏴